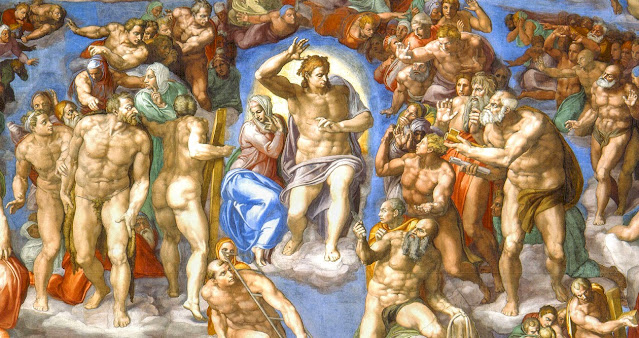Il precedente post, dedicato all’istallazione di Maurizio Cattelan a Bergamo, mi ha dato uno spunto di riflessione (suggerimento offertomi dagli amici Franco Alberto e Pia, che grazie anche ad alcune divergenze di vedute sono fonte di idee interessanti) ha messo in luce la percezione della gente riguardo alle opere d’arte contemporanee.
 |
Tiziano Vecellio – Amor sacro e amor profano, 1515 – Olio su tela cm 118 x 278 – Galleria Borghese, Roma
Di
fronte ad un dipinto, ad una scultura o ad altre espressioni artistiche che non
siano pittura figurativa, spesso la reazione porta alla conclusione che il fine
ultimo sia quello che porta al guadagno e/o alla fama, insomma se qualcuno
realizza un’opera poco comprensibile nell’immediato lo fa per soldi o per farsi
notare.
Non
è mia intenzione negare questa possibilità anzi, posso anche condividerla ma c’è
differenza tra le opere contemporanee e quelle del passato?
Grandi
artisti come Tiziano non lavoravano certo gratuitamente, si facevano pagare
profumatamente tanto che non tutte le persone, anche benestanti, potevano
permettersi i loro dipinti.
Cosa
dire del tanto celebrato, anche da chi non ha il minimo interesse per l’arte,
Michelangelo Buonarroti che, chiamato da Papa Giulio II per affrescare la volta
della Cappella Sistina, si lasciò convincere solo dopo l’offerta di un lauto
compenso, infatti inizialmente aveva rifiutato la commissione in quanto: “sono
uno scultore, non sono un pittore”.
Mentre
riguardo a Tiziano e Michelangelo a nessuno viene in mente che abbiano
realizzato i loro capolavori per fama o denaro, succede esattamente il
contrario se i dipinti o le istallazioni sono realizzate da artisti del nostro
tempo.
Siamo
tutti affascinati dall’idea che il nostro lavoro venga apprezzato da più gente
possibile, l’ego umano è smisurato, cosi come tutti cerchiamo di monetizzare il
nostro lavoro, ma questo non impedisce che dietro gli sforzi ci sia qualcosa in
più.
L’arte
andrebbe “vista” con lo sguardo più ampio possibile, tralasciando quei retro
pensieri che oggi vanno tanto di moda, vedere di ogni cosa solo il lato oscuro,
considerandolo il solo lato possibile.
Gli
artisti da sempre hanno legato le loro opere al profitto ma un appassionato
deve andare oltre, a me non interessa se Picasso ha guadagnato un sacco di
soldi vendendo i suoi quadri, ne tantomeno se i dipinti di Cezanne vengono
battuti all’asta per milioni di euro, sono più attratto dai concetti che questi
pittori hanno espresso, sono interessato dalle dinamiche emerse dalle loro
opere, dinamiche che hanno influenzato l’arte a venire, ma non solo l’aspetto
artistico, anche, e soprattutto, quello sociale e culturale.
Il presente è e sarà sempre figlio del passato e genesi del futuro.







.jpg)
.jpg)