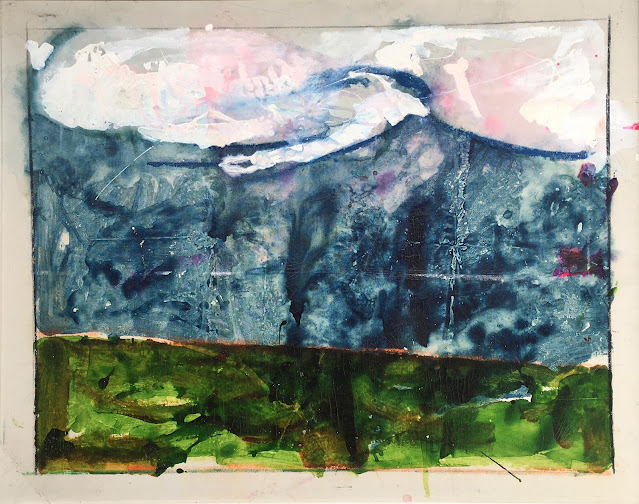Libero
dal giogo asfissiante del lavoro, in queste ultime settimane ho potuto
dedicarmi alla “ricerca” di sfumature disseminate nel mondo della mia passione,
l’arte.
Hans Hartung –
Rayonnement, 1962 – Olio su tela cm 65 x 177 – Musei Vaticani, Città del
Vaticano
Ho
incontrato alcuni addetti ai lavori, insegnanti, galleristi e, naturalmente,
artisti, discorrendo con loro ho cercato di sviluppare un tema che ultimamente mi
incuriosisce, l’opera d’arte e il mercato.
Lo
spunto è nato seguendo un’intervista di una pittrice che sosteneva la
differenza tra il dipinto da vendere e quello artistico, sottolineando che se
dipingeva seguendo una precisa narrazione, un fine puramente artistico, senza
pensare ad un eventuale vendita, la percentuale di probabilità che l’opera
potesse essere venduta è estremamente bassa.
Al
contrario se alla base del dipinto c’è la ricerca di un soggetto commerciabile le
probabilità di vendita si impennano.
Questo
mi ha portato immediatamente ad una prima conclusone, se è arte non si vende,
se segue dettami ornamentali e/o legati alla moda del momento le possibilità di
guadagno sono molto più alte.
Ho
proposto questa mia teoria alle persone che ho incontrato e in linea di massima
l’hanno confermata, qualcuno a denti stretti (l’hanno fatto capire anche se non
lo hanno detto apertamente) altri senza mezzi termini hanno ribadito il
concetto che ho proposto.
Spesso
confondiamo il bel paesaggio, la bella natura morta, con l’arte nel suo
concetto spirituale, questo è spesso dovuto all’ancoraggio della gente verso il
secolo antecedente il 900, ritratti, scene di genere, tramonti, marine, sono
soggetti che vengono considerati artistici, altre forme meno “reali” fanno
storcere il naso.
Dobbiamo
però evitare di considerare il mercato una cosa unica, compatta, c’è mercato e
mercato.
Spesso
il famigerato “mercato dell’arte” ci porta ad una dimensione precisa, quella
delle aste a cifre astronomiche, delle provocazione fatte a suon di milioni, ma
quello è solo uno il lato elitario, quello che mediaticamente solletica la
fantasia e l’indignazione della gente. In ombra rispetto ai casi più eclatanti
c’è un mercato minore (a livello economico, inteso come prezzo della singola
opera) che vede impegnati migliaia di artisti e di collezionisti, a questo va
aggiunto il mercato dove l’acquisto non è più spinto dall’investimento o dal
piacere di possedere l’opera d’arte, l’unico scopo è quello di acquistare un
dipinto che si “abbini” al colore delle preti o ai mobili, insomma un mercato
decorativo.
Siccome
il mondo non è solo quello che ci propinano i media non possiamo non pensare ai
dipinti, alle sculture, alle fotografia, che entrano nelle nostre case, nelle
abitazioni di chi non ha molto denaro da investire nell’arte, la domanda, come
direbbe qualcuno, sorge spontanea: La gente comune non è interessata all’arte,
preferendo la bellezza decorativa, o l’arte, nel suo essere “oltre” il tempo
presente, non può essere apprezzata ed “utilizzata” per scopi ornamentali?






.jpg)